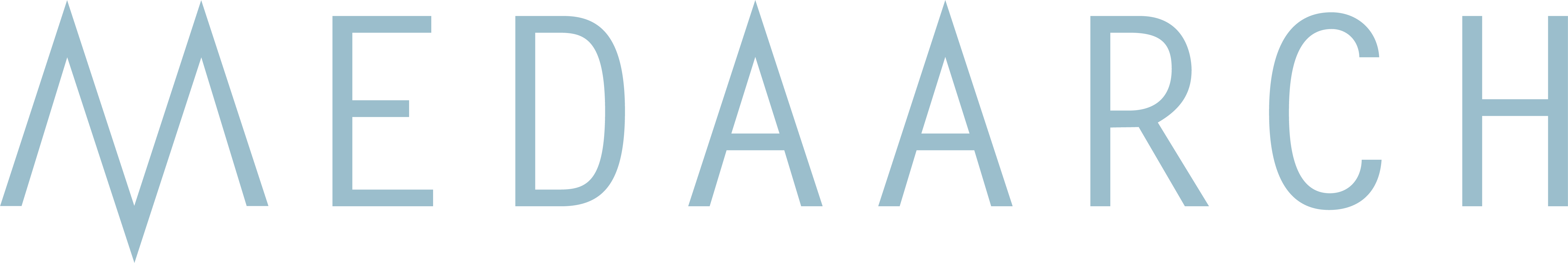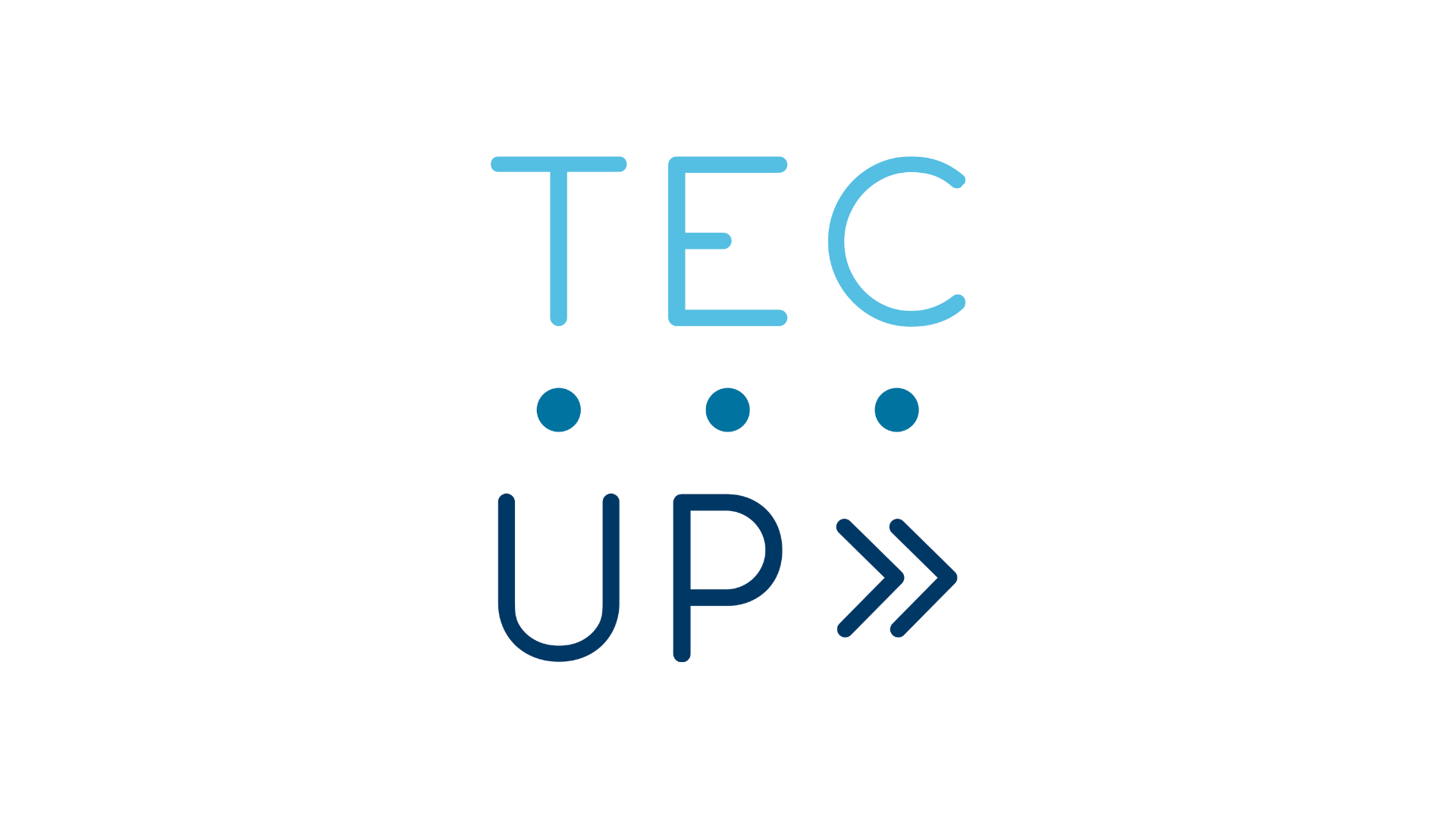Creare insieme le città che desideriamo
Cultura, Immaginario e Partecipazione: il confronto al MAC Fest con Amleto Picerno Ceraso e Agostino Riitano
Lo scorso venerdì 29 agosto, all’interno del MAC Fest – Festival della Musica, dell’Arte e della Cultura, evento multidisciplinare gratuito promosso da Macass APS a Cava de’ Tirreni, si è tenuto un incontro ispirante con Amleto Picerno Ceraso, CEO di Medaarch, e Agostino Riitano, Direttore di candidatura per Torino 2033 – Capitale Europea della Cultura, con esperienze come project manager di Matera 2019, direzione di Procida 2022 e responsabilità su Pesaro 2024.
“Situare Utopie. La cultura che trasforma la città” è stato il titolo del talk che ha visto i due relatori confrontarsi con il pubblico su alcuni temi chiave per il futuro delle città: la cultura come strumento di trasformazione, il ruolo attivo dei cittadini nella produzione culturale, e il potere dell’immaginario come leva politica e sociale.

Un dialogo intenso e ricco di visioni, in cui si è riflettuto su come l’arte, la partecipazione e l’immaginario possano diventare strumenti per ripensare le nostre città e rafforzare il legame tra cittadini, territorio e futuro.
Nel corso dell’appuntamento, sono emerse parole chiave come co-creazione, cittadinanza culturale, innovazione, tradizione e desiderio, tutte legate da un filo comune: la cultura non come ornamento, ma come leva strategica di sviluppo e consapevolezza collettiva.
Tra le espressioni più originali e potenti emerse dal dibattito, l’idea che la cultura possa essere un “vettore di sviluppo locale”: un neologismo che indica una spinta verso il cambiamento, non sempre lineare o definito, ma comunque generativo e trasformativo. In quest’ottica, si è sottolineato come la cultura debba evolversi dal semplice consumo alla co-creazione, mettendo al centro i cittadini non più come fruitori passivi, ma come generatori di senso.
Nell’epoca che stiamo vivendo, la cultura non può più essere intesa come un semplice contenuto da consumare. È necessario capovolgere la prospettiva: il cittadino non è più spettatore passivo, ma protagonista attivo, co-creatore del fatto culturale. In questo senso, la cultura diventa vettore di “sviluppo” locale — un cambiamento non lineare, ma dinamico, talvolta scivoloso, sempre fertile.

Dalla Fruizione alla Generazione
Parlare oggi di esperienza culturale significa abbandonare l’idea di un prodotto chiuso, offerto a un pubblico da intrattenere. Significa invece promuovere processi partecipativi in cui i bisogni, i desideri e le visioni dei cittadini diventano parte stessa dell’opera culturale. Non si tratta solo di “mettere in scena”, ma di costruire insieme ciò che va in scena, ciò che diventa patrimonio condiviso.
Questa visione è stata ben rappresentata in contesti emblematici come Matera (Capitale Europea della Cultura 2019) e Procida (Capitale Italiana della Cultura 2022), dove si è parlato esplicitamente di cittadinanza culturale. In quelle esperienze, si è aperta una stagione nuova, forse irripetibile, in cui i cittadini sono stati chiamati a fare i conti con una dimensione ampliata della propria identità: non solo abitanti del luogo, ma anche custodi e co-progettisti del loro immaginario futuro, capaci di accogliere anche i turisti non come visitatori fugaci, ma come cittadini temporanei.

Come replicare esperienze come quelle di Matera e Procida?
Matera e Procida hanno vinto sulla dimensione prospettica dell’immaginario e del desiderio. Due territori che hanno saputo andare oltre la dimensione dell’evento per generare processi culturali profondi e trasformativi, capaci di lasciare un’eredità viva nelle comunità.
Ma come replicare queste esperienze in altre città? È questa la sfida lanciata anche dalla platea durante l’incontro. Non si tratta di copiare modelli, ma di individuare per ogni territorio la propria prospettiva di immaginario, dove il desiderio sia il motore e l’immaginario la meta. Ogni città, piccola o grande che sia, può e deve interrogarsi su quali siano i temi autentici che muovono la sua comunità e trasformarli in visione condivisa.
Il successo di Matera e Procida non sta (solo) nei numeri o negli eventi. Sta piuttosto nella capacità di attivare un immaginario collettivo, alimentato dal desiderio. In queste città, la cultura ha saputo farsi sfida e visione, riuscendo a individuare una prospettiva condivisa. Lì, le comunità sono diventate laboratori vivi, spazi in cui riflettere sui grandi temi della contemporaneità a partire da bisogni reali e radicati, generando un cambiamento autentico.

Il Tempo giusto per far suonare Tradizione e Innovazione
Un altro nodo cruciale emerso nel dibattito — tenutosi al MAC Fest con Amleto Picerno Ceraso e Agostino Riitano — è quello del tempo. Innovazione e tradizione non sono poli opposti, ma note di una stessa melodia, a patto che si sappia trovare il tempo giusto in cui farle suonare insieme. Senza questo sincronismo, l’innovazione può risultare fuori tono, distonica, mentre la tradizione rischia di farsi sterile rituale.
In questa dimensione temporale, gli artisti assumono un ruolo centrale. Essi non appartengono semplicemente al costume o alle mode, ma vivono in una dimensione altra, a-temporale, che consente loro di decifrare i segnali deboli del presente e di proiettare immaginari futuri.

Cultura come Eredità Consapevole
In definitiva, la cultura serve ad accrescere la consapevolezza e la capacità delle comunità di progettare il proprio futuro. Non si tratta solo di salvaguardare beni tangibili o intangibili, ma di lasciare alle nuove generazioni un patrimonio fatto di visione, identità, partecipazione e desiderio. Perché ogni atto culturale che nasce da un processo di co-creazione è già, di per sé, un lascito. Non resta, ma continua. Non conserva, ma trasforma. Non finisce, ma comincia. Ed è da qui che le città si trasformano e le utopie imparano ad abitare il reale.
Condividi:
Ricerche simili